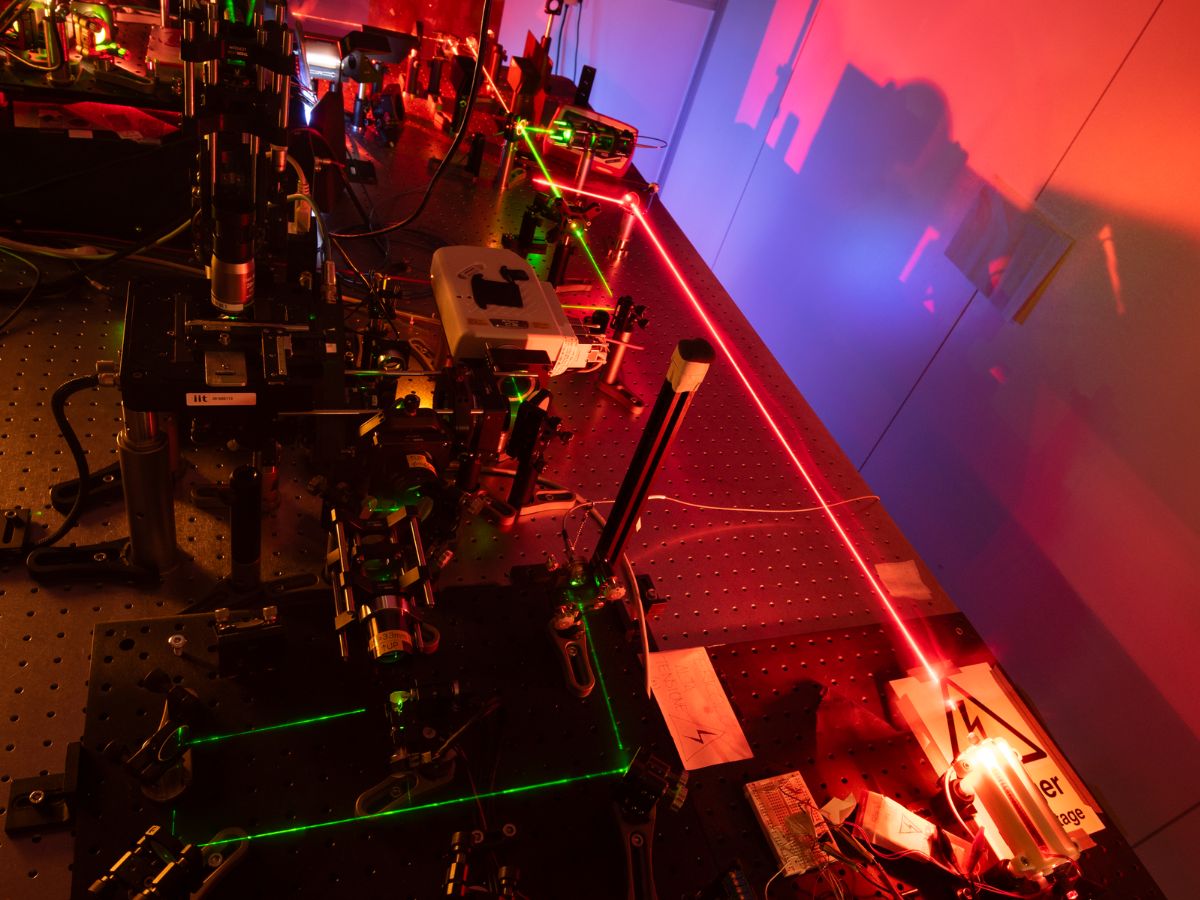Resoconto dell’evento “Connessioni e intrecci nella ricerca oncologica. Meccanismi, innovazioni tecnologiche e terapie” con Andrea De Censi, Francesco Nicassio, Velia Siciliano, Marco Tagliamento, moderati da Nicola Tirelli. In collaborazione con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro
La ricerca sul cancro è un’indagine scientifica multidisciplinare, dove si intrecciano competenze e persone, ma anche dimensioni fisiche, dalle piccole molecole che compongono i geni e le proteine, alle cellule dei tessuti, fino al corpo intero del malato oncologico: questo è il disegno tracciato durante l’evento “Connessioni e intrecci nella ricerca oncologica”, il 24 ottobre, dentro Palazzo Ducale, in occasione del Festival della Scienza a Genova. Una tavola rotonda che ha portato insieme alcuni dei migliori ricercatori e ricercatrici italiane attive nel settore: Marco Tagliamento, oncologo e ricercatore universitario, che lavora presso l’ospedale San Martino e Università di Genova; Francesco Nicassio, biologo molecolare e coordinatore del Centro di Scienze Genomiche dell’IIT a Milano; Velia Siciliano, biotecnologa medica, a capo del laboratorio di Synthetic and Systems Biology for Biomedicine dell’IIT a Napoli, e Graziana Scavone, biologa, collaboratrice di ricerca sanitaria presso l’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova. L’evento è stato promosso dall’IIT in collaborazione con la Fondazione AIRC, e ha visto in veste di moderatore Nicola Tirelli, Associate Director for Education dell’IIT, e come promotore e organizzatore Davide De Pietri Tonelli, responsabile del Neurobiology of miRNA Lab dell’IIT a Genova.
Il panel ha illustrato i risultati più significativi ottenuti nei loro rispettivi campi, sia nel corso della storia della scienza moderna, dove si contano diversi Nobel Laureate, sia grazie al loro lavoro di ricerca quotidiano.
“In Italia ricordiamo Renato Dulbecco che spinse per il progetto di lettura del genoma umano”, ha dichiarato Nicassio, rammentando come la storia dello studio dei tumori sia cambiata nel momento in cui lo scienziato italiano intuì che era necessario comprendere il funzionamento dei geni. Lo scrisse nell’articolo del 1987 su Science A Turning Point in Cancer Research: Sequencing the Human Genome. “Oggi con le attuali tecnologie possiamo sequenziare un singolo genoma in pochissime ore, e questo ci permette di trarre le informazioni specifiche sui tumori, sui singoli geni coinvolti, così che possiamo agire con maggiore precisione” ha spiegato Nicassio. Il ricercatore dell’IIT, grazie a un primo finanziamento AIRC, a cui ne sono seguiti altri, diede avvio al suo gruppo di ricerca per studiare alcuni specifici geni coinvolti nei tumori, come per esempio quello al seno (https://opentalk.iit.it/levoluzione-del-tumore-e-scritta-sul-genoma/). Più nello specifico la sua attenzione è rivolta al DNA non codificante: “significa concentrarsi su quelle porzioni del genoma che, a differenza dei geni, non producono proteine. Negli ultimi trent’anni, queste regioni sono state identificate come produttrici di molecole di RNA, che giocano un ruolo chiave nella regolazione dei geni. La nostra complessità biologica deriva in gran parte dall’evoluzione di queste sequenze non codificanti e dalle loro funzioni regolatorie. Comprenderne il ruolo, sia nella biologia che nei tumori, quindi, significa esplorare la storia dell’essere umano e allo stesso tempo avere le conoscenze utili per sviluppare nuovi trattamenti e anticipare le diagnosi.”
Il tumore al seno è argomento di studio anche di Graziana Scavone, la quale si dedica, sempre con il supporto di AIRC, a indagare la gonadotossicità delle terapie oncologiche esistenti, ovvero gli effetti negativi che queste potrebbero avere sulla fertilità della donna sottoposta ai trattamenti. “Esaminiamo il tessuto ovarico da donatrici e analizziamo come le terapie influenzano la funzione ovarica. E’ già noto in letteratura, che la chemioterapia tradizionale ha un impatto tossico sulle ovaie, per cui alle pazienti viene sempre offerta la possibilità di preservare la fertilità prima dell’inizio dei trattamenti”.
Il progresso delle ricerche scientifiche sta conducendo verso una nuova classe di farmaci che dovrebbe agire sulle cellule tumorali, evitando quelle sane. Si tratta di trattamenti che sfruttano il sistema immunitario del nostro corpo, o lo imitano nell’azione.
Scavone ha citato come esempio le Antibody-Drug Conjugates (ADC), che sono proteine-anticorpo sintetizzate in laboratorio, e rese “intelligenti” così da riconoscere solo determinate cellule tumorali, rilasciando il farmaco citotossico direttamente nelle cellule maligne. Alcuni di questi farmaci sono già in uso in pratica clinica, altri sono in fase di studio per valutarne efficacia e livello di tossicità.
La relazione tra sistema immunitario e cancro è stato oggetto di un premio Nobel per la medicina nel 2018, assegnato a James P. Allison e Tasuku Honjo per la scoperta dei meccanismi con cui le cellule tumorali riescono a eludere il sistema immunitario, aprendo la strada allo sviluppo dell’immunoterapia del cancro. Marco Tagliamento ha menzionato tale ricerca sottolineando come abbia rappresentato un altro passo in avanti nell’ideazione di nuove terapie. “Da tale ricerca è stato possibile inventare farmaci che ripristinano le capacità del sistema immunitario, andando quindi ad agire sul tumore non direttamente, ma agendo sull’ambiente in cui si forma, armando il sistema immunitario contro di esso”. Tagliamento, inoltre, ha illustrato il proprio progetto di studio clinico sul tumore del polmone e le neoplasie toraciche supportato da AIRC, volto a individuare già in un prelievo di sangue caratteristiche molecolari della malattia che possono influenzare l’efficacia dei trattamenti oncologici.
Anche quest’anno il Premio Nobel per la medicina è stato assegnato a studi sul sistema immunitario (https://opentalk.iit.it/il-nobel-prize-in-medicina-2025-le-cellule-t-e-lequilibrio-del-sistema-immunitario/ ); mentre l’anno precedente era stato rivolto
Il potenziamento del sistema immunitario contro i tumori è la strada che sta perseguendo Velia Siciliano, la quale ha spiegato come la biologia sintetica, un campo della bioingegneria, sia capace di riprogrammare le cellule in risposta a input esterni o interni. “Per esempio, le T-cell sono cellule che appartengono al sistema immunitario e intervengono quando riconoscono una cellula tumorale, colpendola. Tuttavia, con il tempo queste cellule possono perdere efficacia. Grazie alla bioingegneria, possiamo programmare le cellule – che diventano CAR-T, affinché, una volta “stanche” possano riprendere l’attacco contro le cellule tumorali”. Le cellule CAR-T vengono prelevate dal paziente e modificate introducendo una proteina detta CAR, che guida le cellule a riconoscere e colpire specificamente il tumore. Siciliano ha aggiunto che la sua ricerca va oltre la semplice bioingegnerizzazione delle T-cell. “Normalmente le cellule del sistema immunitario comunicano tra loro; l’obiettivo è ristabilire queste reti di comunicazione compromesse attraverso la biologia sintetica, creando sistemi di comunicazione cellulare programmati”. Per le sue ricerche Siciliano ha ricevuto finanziamenti dall’European Research Council.
L’incontro si è concluso con l’intervento della Direttrice Scientifica di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, Anna Mondino, la quale ha riportato alcuni dati statistici di uno studio commissionato al CENSIS (https://www.censis.it/sites/default/files/downloads/Sintesi%20dei%20principali%20risultati%20I%20Rapporto%20Airc%20-%20Censis.pdf): il 90 per cento degli italiani conosce AIRC; e dal rapporto CERGAS che evidenzia che oltre il 47% cento della ricerca oncologica in Italia nel periodo compreso tra il 2016 e il 2023 è stata finanziata dal settore del non profit, la maggior parte da AIRC, grazie al contributo di 4,5 milioni di sostenitori e all’impegno di 20 mila volontari. Un pensiero è andato ai padri fondatori della Fondazione, Umberto Veronesi e Giuseppe Della Porta, che nel 1965, a causa degli scarsi finanziamenti per la ricerca oncologica, ebbero l’idea di creare un sistema supportato direttamente dai cittadini. Grazie a quell’intuizione, Fondazione AIRC oggi sostiene più di 5400 ricercatori e ricercatrici nei loro studi.