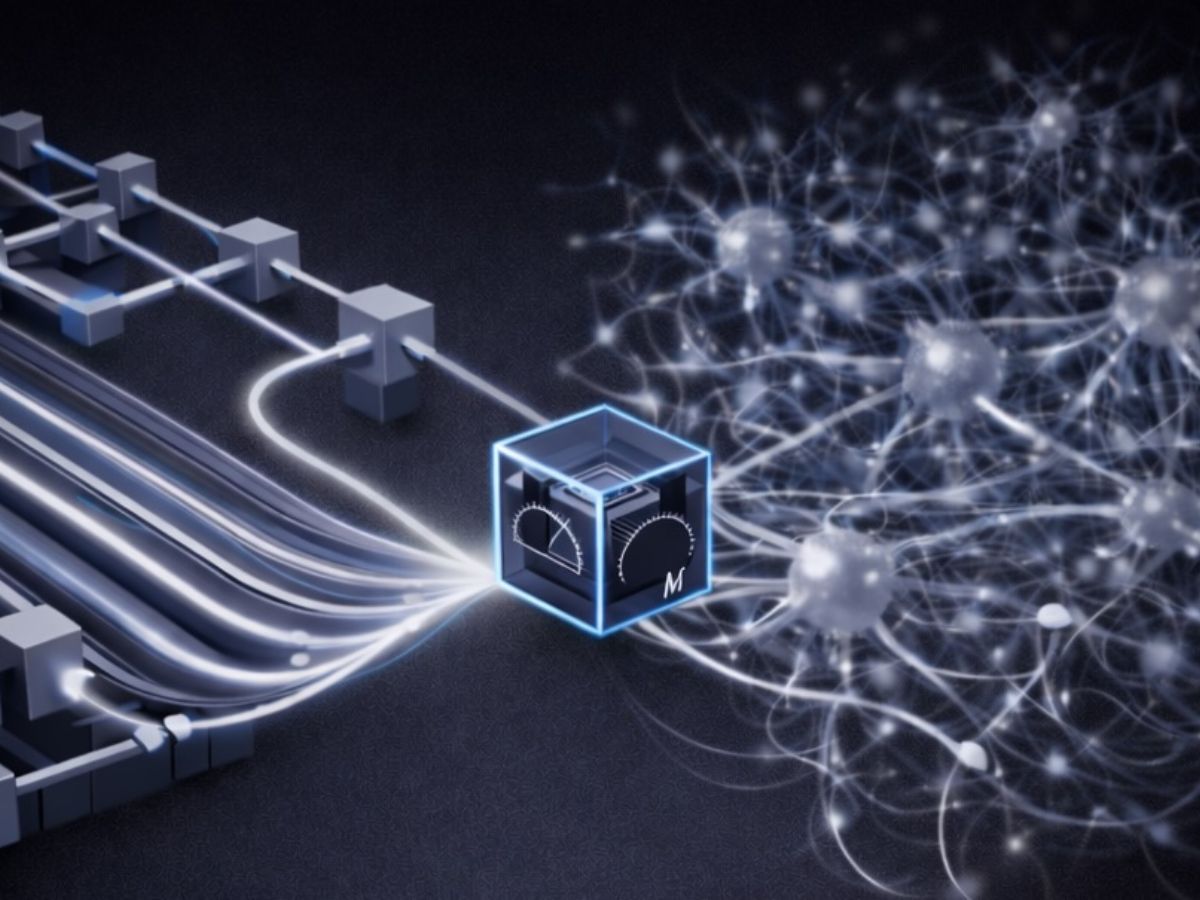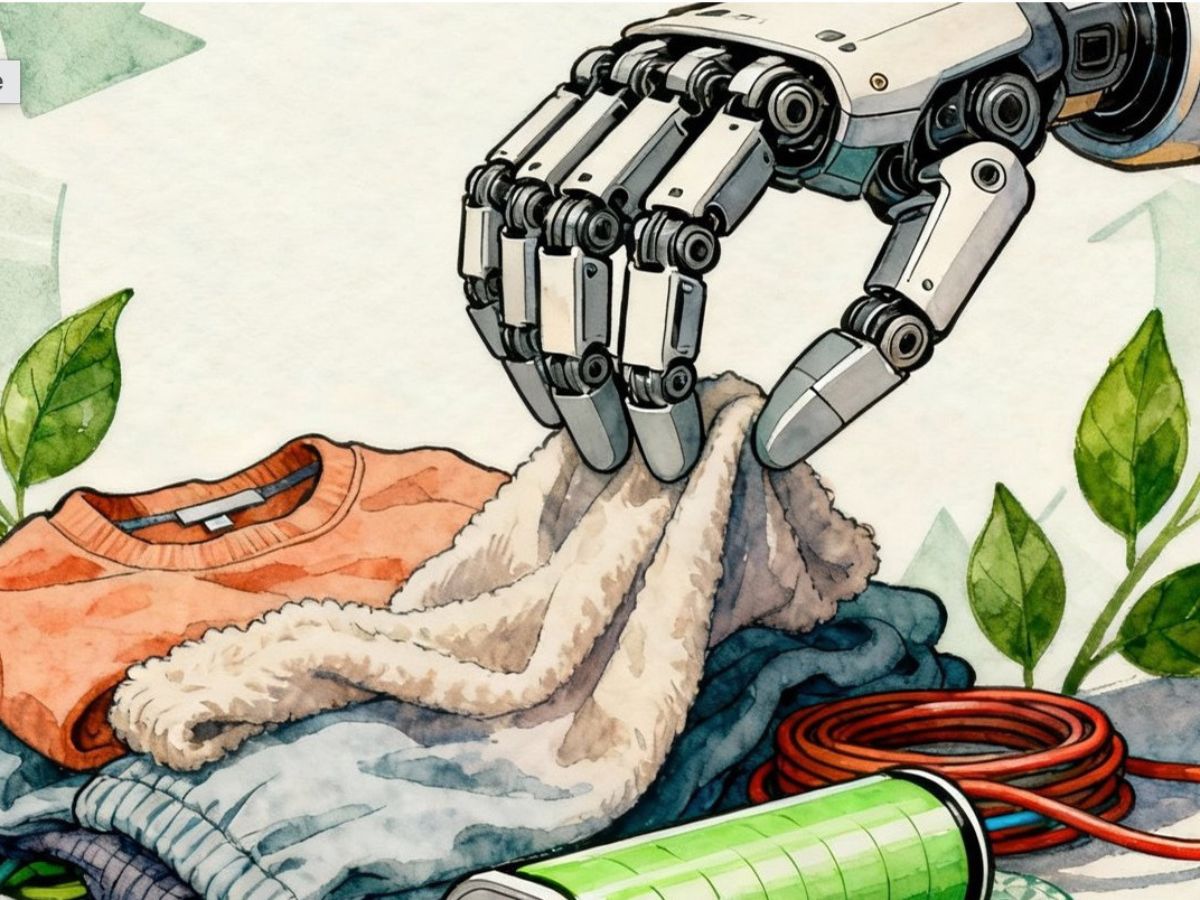Ruggero Bellini ha proiettato sul futuro la cultura di chi lavora in campagna: non si butta niente, si riutilizza tutto. L’ha applicata alla produzione di idrogeno a partire da rifiuti organici – biomassa algale, scarti industriali, resti alimentari – ottimizzando con particolari accorgimenti il processo di fermentazione microbiologica, in modo da renderlo più semplice da gestire e meno costoso. Inoltre insieme a colleghi ha caratterizzato diversi giacimenti esausti di gas naturale per valutarne l’idoneità a fungere da depositi di idrogeno sotterranei non impattanti sull’ambiente esterno
L’idrogeno è considerato il combustibile del futuro. Il fatto che possa fornire energia senza emissioni di CO2 – come è noto, quando brucia emette solo vapore acqueo – e che possa essere ottenuto in modo sostenibile (in questo caso parliamo di idrogeno verde) lo rende una fonte energetica su cui vale la pena scommettere, considerando le sue caratteristiche e le prospettive sullo sviluppo di un’economia circolare e di riduzione dell’uso di combustibili fossili in Unione Europea.
Ne è convinto Ruggero Bellini, oggi all’IIT come ricercatore post-doc nell’unità di ricerca Advanced Materials for Sustainable Future Technologies, dopo una laurea in Biotecnologie agrarie e ambientali all’Università di Perugia e un PhD in Ingegneria chimica alla University of South Wales. Con il suo gruppo, si occupa di idrogeno su due fronti: come produrlo da fonti rinnovabili e come stoccarlo senza pesare troppo sull’ambiente, ricorrendo a spazi vuoti naturali già esistenti.
Perché l’idrogeno ha un’importanza sempre maggiore?
«Oggi il consumo di idrogeno in Europa è di circa otto megatonnellate all’anno, ma secondo le previsioni nel 2050 potrebbe arrivare a 38 megatonnellate, coprendo il 10% del consumo totale di combustibili in Europa. Come sostituto dei combustibili fossili è estremamente valido, perché non produce CO2 quando è utilizzato».
L’idrogeno è tutto uguale dal punto di vista ambientale?
«No, dipende dal metodo di produzione. In Unione europea è in uso una scala di colori per classificare l’idrogeno da questo punto di vista. Oggi il più diffuso in Europa è il cosiddetto “idrogeno grigio”, ottenuto dal gas naturale, la cui produzione comporta emissioni di gas serra non recuperate. Si parla di “idrogeno blu” quando il processo produttivo comporta il recupero e la valorizzazione delle emissioni prodotte. Infine, si parla di “idrogeno verde”, il migliore da questo punto di vista, quando la produzione è ottenuta senza emissioni di CO2 e interamente attraverso processi e fonti rinnovabili. Quest’ultimo purtroppo è il metodo oggi economicamente più costoso. Ma si prevede che entro il 2050 proprio l’idrogeno verde diventerà il tipo più diffuso, anche grazie al miglioramento delle tecnologie che ne faranno scendere il prezzo».
Voi lavorate a un sistema di produzione studiato per abbassarne i costi
«Il nostro sistema di produzione, basato sulla fermentazione oscura (dark fermentation), è interamente basato sull’utilizzo di scarti industriali. Scarti come lo sfalcio del verde, l’umido urbano, residui dei processi di lavorazione del bestiame e altro, attraverso processi che stiamo sviluppando in IIT, possono essere usati per ottenere idrogeno. In particolare, stiamo lavorando a semplificare questo processo, in modo da renderlo più facile da gestire e quindi meno costoso».
Quali sono i problemi principali legati alla fermentazione oscura?
«Il problema è che tutti i processi produttivi basati sulle fermentazioni microbiche esigono che siano mantenute condizioni estremamente controllate: servono reagenti chimici specifici per far sviluppare i microrganismi, c’è la necessità di mantenere diversi parametri costanti, controllare la temperatura… tutto questo alza i costi, con forti impatti sull’efficienza di processo. La mia idea è stata identificare scarti industriali con caratteristiche chimiche e composizione adatte alle necessità dei microrganismi che coltiviamo e ottenere così un processo con minori esigenze di controllo. Ultimamente abbiamo lavorato molto nell’ambito del progetto NEST, finanziato nell’ambito del PNRR: utilizzando scarti solidi come la biomassa algale proveniente dal trattamento di acque reflue (e quindi non utilizzabile come additivo o integratore alimentare), e in particolare lo scarto liquido residuo della produzione di biometano o biogas, siamo riusciti a ottenere un brodo di coltura che ha esigenze molto minori dal punto di vista del controllo. In particolare questo scarto liquido ha rivelato di avere caratteristiche molto adatte al processo di fermentazione: aiuta a regolare il pH e nutre i microrganismi. Sostituendo reagenti chimici con scarti grezzi e riducendo considerevolmente i trattamenti necessari abbiamo abbattuto i costi del processo».
Si ottiene altro oltre all’idrogeno?
«Si ottengono anche acidi organici come acido acetico e butirrico, che possono essere valorizzati in altri settori, per esempio nel packaging alimentare. E una piccola quantità di CO2, che sostanzialmente è quella precedentemente assorbita e incorporata nella biomassa algale: induce un bilancio pressoché neutro in termini di emissioni, essendo compensata dal tipo di materiale che riutilizziamo».
Una volta prodotto, vi occupate anche di dove stoccare l’idrogeno…
«L’idrogeno oggi viene principalmente stoccato in grandi serbatoi in superficie, ovvero al di sopra del terreno. Con la sua diffusione, e quindi l’aumento delle quantità di idrogeno gestito, i serbatoi per lo stoccaggio in superficie non saranno più sufficienti, tenendo conto dei vincoli ambientali che ovviamente impediscono di riempire tutto il territorio di serbatoi. Si devono quindi cercare sistemi più efficienti che garantiscano alti volumi di stoccaggio».
Quali sono i sistemi di stoccaggio dell’idrogeno alternativi?
«Da quattro anni studiamo la fattibilità di stoccare l’idrogeno nei giacimenti esausti di gas naturale, di cui in Italia abbiamo una buona disponibilità e che oggi utilizziamo per stoccare il gas che acquistiamo all’estero. Sul territorio italiano c’è una disponibilità di quasi 19 miliardi di metri cubi di spazio disponibile per lo stoccaggio di gas al di sotto del terreno, a 1.200-1.500 metri di profondità. Il nostro lavoro è stato verificare la fattibilità dello stoccaggio di idrogeno in nove di queste strutture, studiando la geologia e la chimica delle rocce, le acque di formazione presenti, i microrganismi… ci sono caratteristiche per cui l’idrogeno potrebbe interagire chimicamente? La roccia ha una porosità compatibile? Rispondendo a queste e simili domande si può stabilire quali giacimenti sono più o meno adatti a essere utilizzati per stoccare l’idrogeno, naturalmente sotto pressione, in grandi quantità. In particolare noi ci siamo occupati del rischio microbiologico: infatti anche dei microrganismi potrebbero interagire con l’idrogeno, e con tutto il sistema-giacimento, col rischio di creare reazioni chimiche problematiche, provocando danni alle strutture e residui al momento dell’uso».