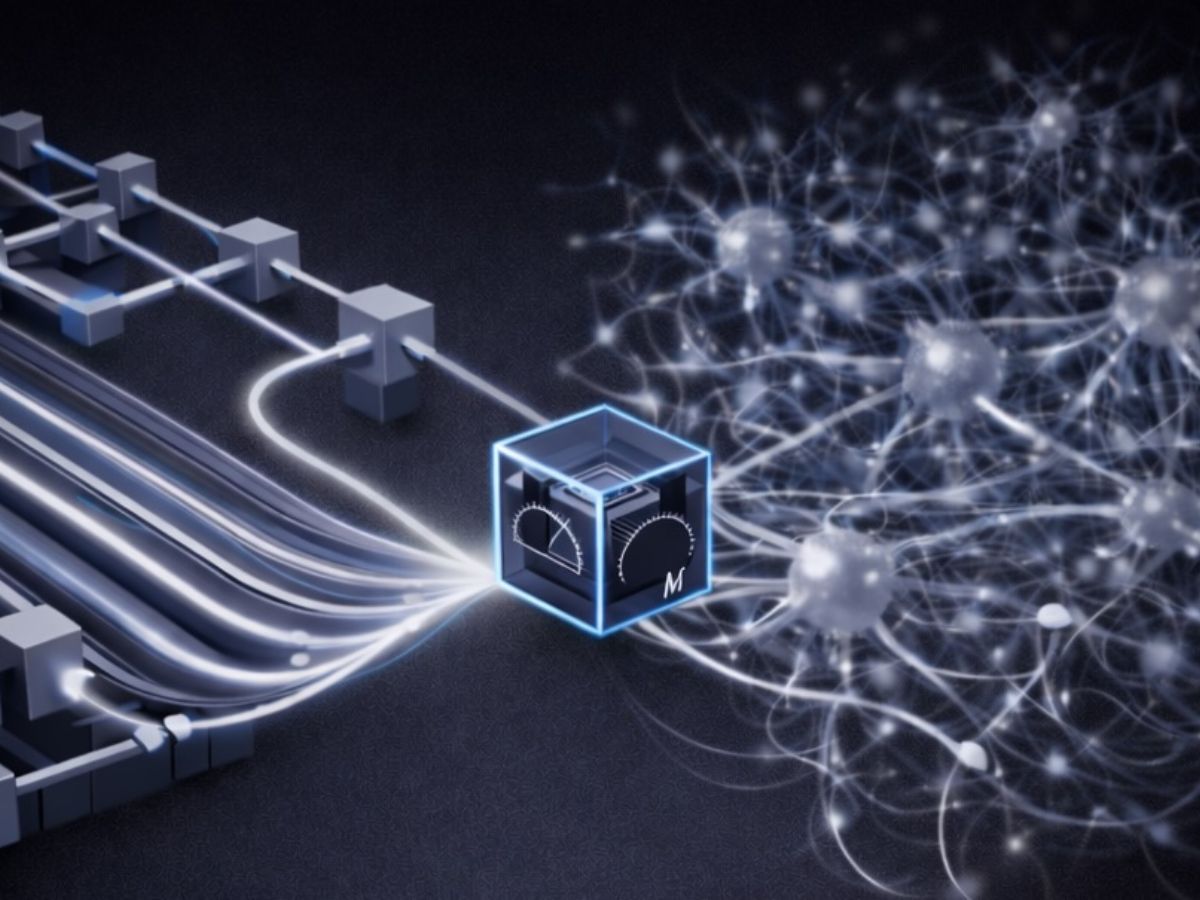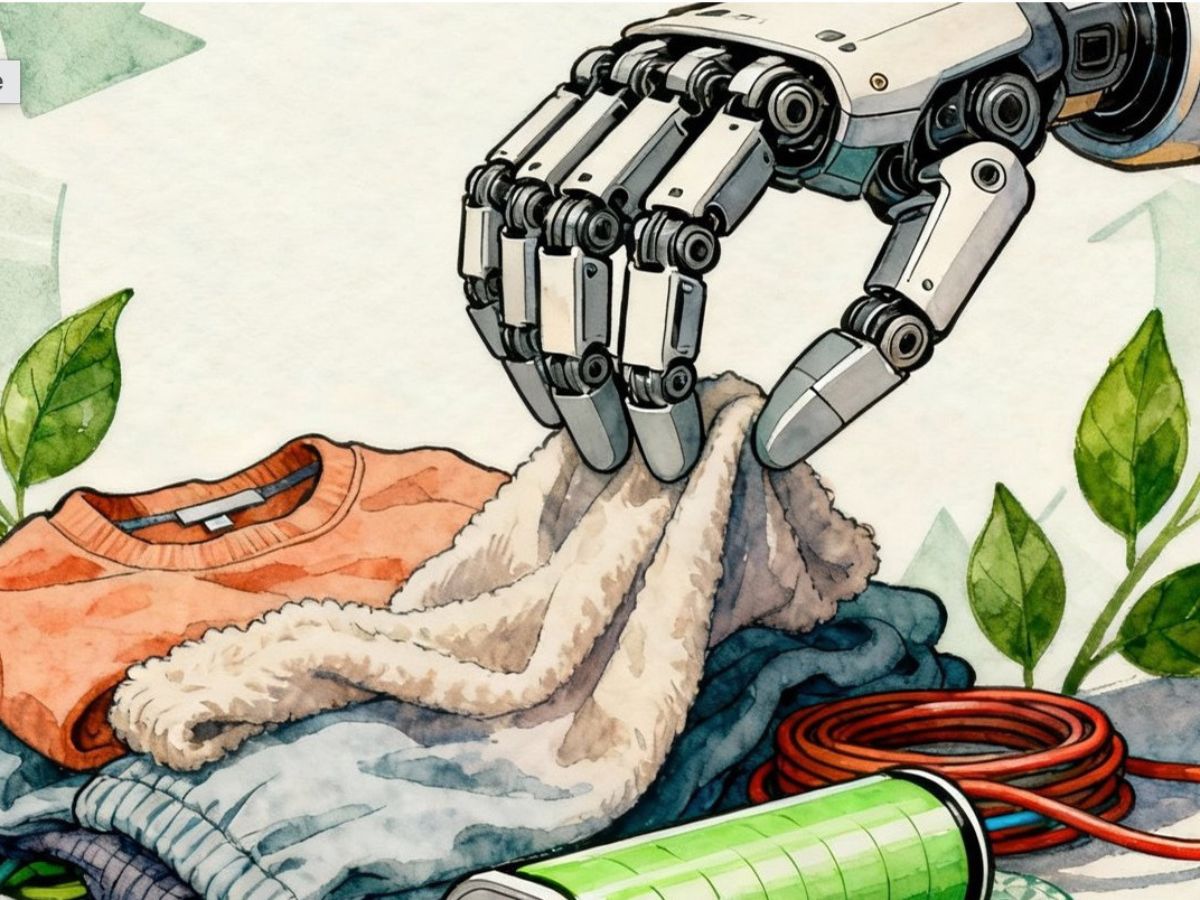Intervista a Giancarlo Sturloni, giornalista scientifico ed esperto di comunicazione del rischio
In un’intervista allo Spiegel il filosofo Hans Jonas aveva dichiarato, riferendosi all’inerzia del comportamento umano nei confronti del mondo naturale: “Chi non è minacciato personalmente in modo diretto non si sforza di fare una revisione del proprio modo di vivere. Nel caso di una minaccia incombente è diverso, individualmente e collettivamente”. Il virus SARS-CoV-2 ci ha costretti a un cambiamento, in tutto il mondo, in modo repentino, non lineare e non omogeneo. L’umanità ha risposto all’emergenza come di fronte ad “una guerra” e nei piani per il futuro spesso si sente dire “che non sarà tutto come prima”. Dovremo “convivere” con il virus. Eppure Ulrich Beck, teorico della società del rischio lo aveva già anticipato: il prodursi di rischi globali è diventato una norma. Cosa, allora, non ha funzionato nel prevedere e gestire tale “normalità”? Ne abbiamo parlato con Giancarlo Sturloni, giornalista scientifico ed esperto di comunicazione del rischio.
In quale modo la percezione del rischio di questa pandemia ha influito sulle scelte politiche dei diversi Paesi?
La percezione di un rischio indirizza le preoccupazioni e quindi le scelte che ne conseguono. Per quanto riguarda COVID-19, nel nostro Paese il rischio è stato inizialmente sottovalutato. Abbiamo creduto di non poter vivere sulla nostra pelle quello che stavano vivendo i cittadini di Wuhan, e questo ha causato anche un ritardo negli interventi. Nelle prime settimane di febbraio, anche per la bassa percezione del rischio, non abbiamo capito che l’epidemia era già arrivata in Italia e non siamo stati in grado di riconoscere i primi casi sospetti. Mentre a fine febbraio, quando era ormai chiaro che il virus circolava anche da noi, c’è stato un secondo momento di sottovalutazione del rischio che ha coinciso con le rassicurazioni date da diversi esponenti politici nei giorni della campagna “Milano non si ferma”. L’iniziativa, che era stata realizzata per salvaguardare l’immagine e l’economia del Paese, ha indotto i cittadini a pensare di poter riprendere la loro vita normale, in contrasto con le indicazioni che avevano ricevuto pochi giorni prima per proteggersi dal contagio. È stato un grave errore comunicativo.
Un primo sondaggio sulla percezione del rischio in Italia realizzato dall’Osservatorio Observa nelle prime settimane di marzo riportava che la fascia di età meno sensibile al rischio pandemia era quella dei giovani. Quale può essere la ragione di questa differenza?
I risultati non sono sorprendenti. In generale le fasce più giovani, in particolare i giovani maschi, sono meno propense a preoccuparsi dei rischi. In questo caso specifico, però, è accaduto che molte istituzioni, riprese dai mass media, hanno sottolineato che l’epidemia interessava principalmente gli anziani con patologie pregresse, inducendo i più giovani a non temere di esporsi al contagio. Se da un lato è vero che le persone anziane sono più a rischio, dall’altro questa scelta comunicativa tradisce un tentativo di rassicurare la popolazione con un messaggio fuorviante – “muoiono solo gli anziani con altre patologie” – mentre sappiamo che in realtà nessuno può ritenersi al sicuro.
La comunicazione, e quindi anche il linguaggio utilizzato, è importante nel gestire un’emergenza. Nel caso della pandemia di COVID-19 si usa spesso un linguaggio bellico, con termini come “guerra”, “battaglia”, “nemico”, molto efficace a mobilitare le persone e a richiamare un senso di responsabilità individuale. È il più adeguato o ci potrebbero essere alternative ugualmente efficaci?
L’uso del linguaggio bellico in medicina risale al Seicento e si afferma nell’Ottocento con la teoria dei germi che individua negli agenti patogeni la causa delle epidemie; le metafore sono quelle dell’invasione e del corpo come fortezza da proteggere da un aggressore esterno. Storicamente la medicina si è sviluppata anche per rispondere alle conseguenze delle guerre, condividendo il linguaggio e l’organizzazione militare. È per questi motivi che ancora oggi sopravvive un gergo bellico ottocentesco: tutti i leader delle principali nazioni coinvolte dalla pandemia hanno parlato di una guerra contro un nemico invisibile. Questo linguaggio non è però privo di conseguenze: se da un lato può essere utile per mobilitare le persone, dall’altro chiede ai cittadini di ubbidire con disciplina militare; non fa leva sulla responsabilità dei singoli, né richiede che i governi debbano spiegare o giustificare le loro decisioni. Gestire un’emergenza sanitaria come una guerra può anche favorire svolte autoritarie. L’impiego delle metafore dell’invasione ha già portato alla chiusura delle frontiere, sebbene l’OMS consideri questa misura controproducente. Forse non abbiamo un’alternativa altrettanto potente delle metafore militari, ma servirebbe maggiore consapevolezza delle possibili conseguenze.
Nella comunicazione sono coinvolti anche gli scienziati, a volte intervenendo in modo isolato e diventando fonte per i mass media. Quali consigli daresti loro per raccontare le loro ricerche legate al COVID-19?
Uno scienziato che racconta le proprie ricerche, in modo chiaro, è la migliore fonte del giornalismo scientifico; deve però essere capace di inserire la propria ricerca in un contesto più ampio, che per esempio includa anche gli aspetti etici e sociali. Nel caso di un’emergenza come quella che stiamo vivendo è inoltre importante avere competenze specifiche nella comunicazione del rischio, perché anche un errore banale può mettere in pericolo la vita di molte persone. Spesso gli esperti e le istituzioni tendono a sminuire il rischio nel tentativo di rassicurare le persone, ma questo ha l’effetto di ridurre la loro percezione del rischio e talvolta di esporle al pericolo. Un altro problema emerge quando l’esperto entra in conflitto con i colleghi, alimentando la confusione. Ma il problema principale, nella comunicazione del rischio, è la mancanza di una comunicazione istituzionale autorevole e capace di offrire informazioni coerenti, tempestive e aggiornate. Gli scienziati non sbagliano a esporsi sui mass media, ma non devono mai dimenticare che la scienza è un’impresa collettiva dove il consenso scientifico è l’unica guida affidabile in situazioni così incerte e complesse come le epidemie. Servono istituzioni scientifiche capaci di offrire un quadro coerente e il più possibile completo delle conoscenze disponibili; l’OMS è un buon esempio perché può contare su scienziati di diverse discipline: dall’epidemiologo al ricercatore sociale, dallo psicologo delle emergenze al comunicatore del rischio.
Come dovrebbe avvenire la gestione del rischio durante un’emergenza?
Per poter funzionare, la gestione di un’emergenza deve essere pianificata in “tempo di pace”, cioè prima della crisi, in base ai diversi scenari, più o meno probabili, che potrebbero verificarsi. Questi scenari possono essere delineati in base alle esperienze pregresse: le pandemie sono eventi ricorrenti e dal 2003 l’OMS esorta tutti i governi a dotarsi di un piano di emergenza pandemico. Meglio ancora se il piano è costruito con la partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti ed è condiviso con la cittadinanza. In Italia, ma anche in altri Paesi, è mancata una pianificazione delle risposte all’emergenza.
Cosa si potrebbe fare di più e cosa non ha funzionato nel nostro Paese?
In generale, abbiamo una carenza di professionalità nell’ambito della comunicazione del rischio, anche dentro molte istituzioni chiamate a gestire le emergenze. Come in altre occasioni, è inoltre emerso un problema di coordinamento tra le diverse istituzioni e l’incapacità di “parlare con una voce sola”, offrendo ai cittadini messaggi chiari e coerenti. Per il futuro, mi auspico anzitutto una maggiore preparazione in tempo di pace, con la creazione di unità di crisi con ruoli e competenze ben definiti, in grado di attivarsi rapidamente in caso di necessità. Altrimenti è inevitabile trovarsi sempre in ritardo sugli eventi e subirne le conseguenze. La risposta alle emergenze va pensata e preparata prima che l’emergenza si verifichi.