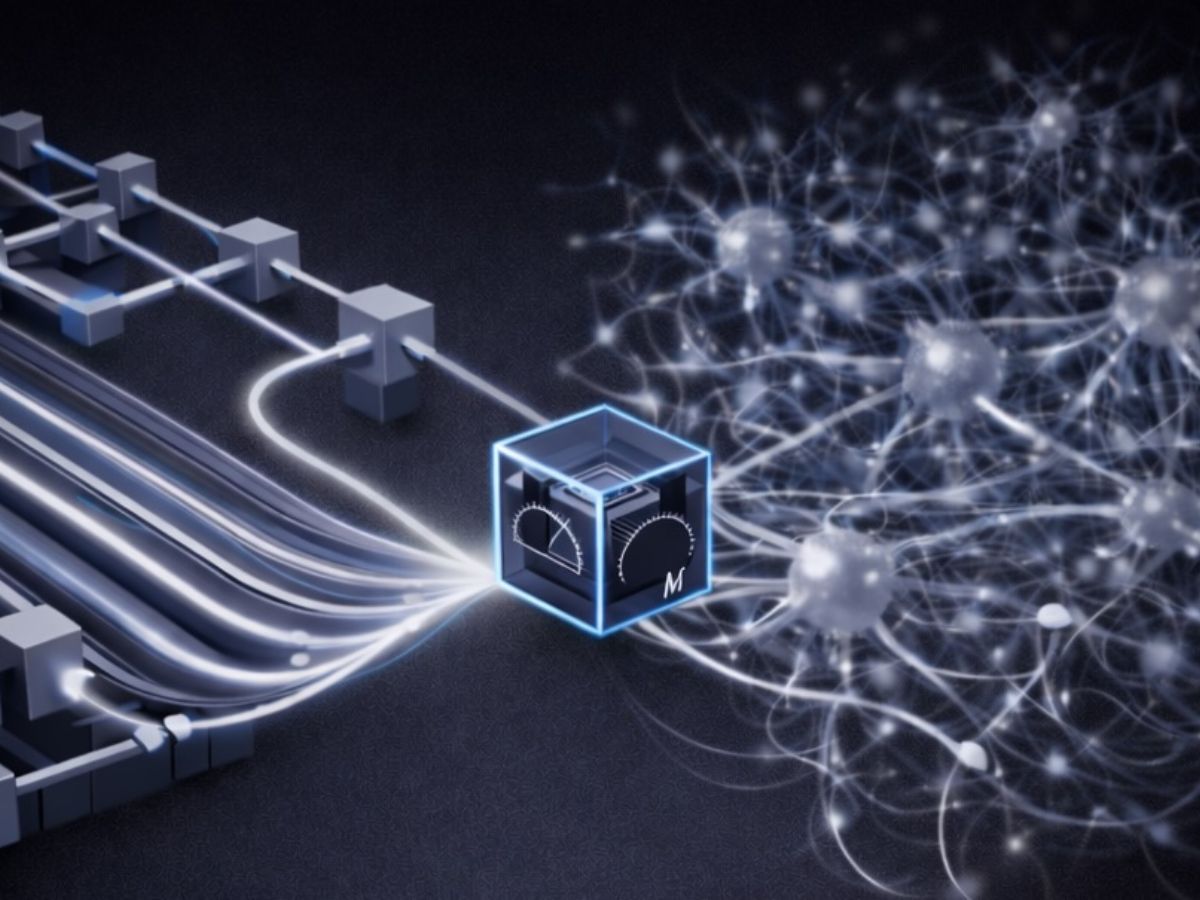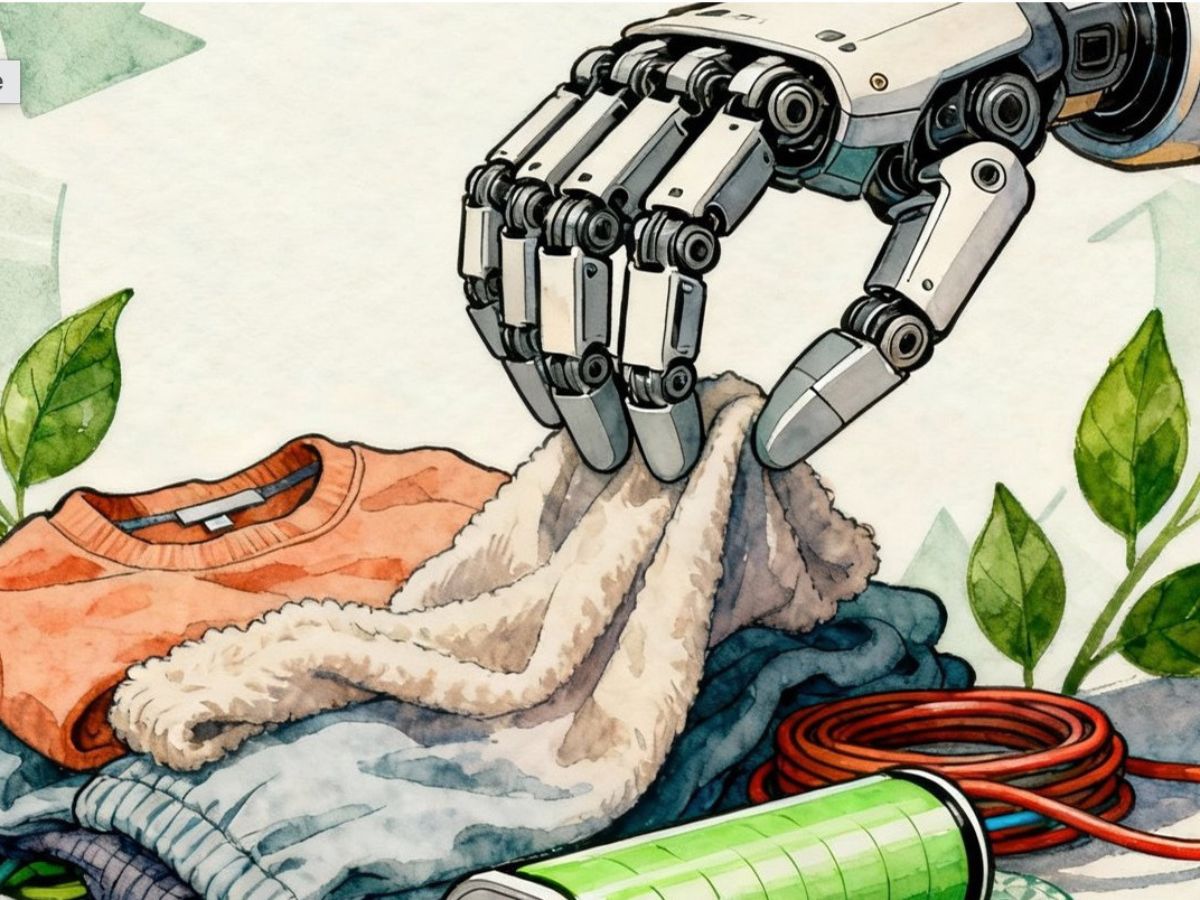Isabella Poli, ingegnera ed esperta in tecnologie energetiche e chimiche sostenibili, lavora all’IIT presso il Center for Sustainable Future Technologies di Torino. La sua ricerca si concentra sulla sintesi di materiali semiconduttori e conduttori innovativi, in grado, attraverso reazioni fotocatalitiche, di ricavare combustibili solari sia dall’acqua sia dalla CO2 sottratta all’atmosfera. Si tratta di materiali iperporosi, in grado anche di rimuovere dall’acqua sostanze inquinanti, sia mediante procedimenti di riduzione catalitici sia fisici. Anche nella produzione dei nuovi materiali di sintesi l’attenzione per la sostenibilità è in primo piano
Isabella Poli, dopo una laurea triennale in Ingegneria Energetica presso il Politecnico di Milano, una magistrale in Tecnologie Energetiche Sostenibili presso la TU Delft University e il dottorato di ricerca in Tecnologie Chimiche Sostenibili presso l’Università di Bath, nel 2019 è entrata a far parte del gruppo Materiali Avanzati per Optoelettronica dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), dove oggi coordina il gruppo di Materiali e Tecnologie Energetiche Applicate presso il Center for Sustainable Future Technologies, un centro di ricerca interdisciplinare costituito in sinergia tra IIT e Politecnico di Torino.
Si occupa in particolare di sintesi e lavorazione di nuovi materiali per le reazioni fotoelettrochimiche e fotocatalitiche, materiali capaci cioè di utilizzare l’energia proveniente dalla luce del sole per ottenere reazioni come la scissione dell’acqua, la riduzione dell’anidride carbonica, la fotodegradazione degli inquinanti organici.
Su che cosa punta in particolare la sua ricerca?
«Stiamo lavorando principalmente su semiconduttori, vale a dire materiali in grado di assorbire la luce solare e convertirla in un’altra energia: prima di lavorare in IIT ho iniziato con il fotovoltaico, in cui l’energia solare è convertita in energia elettrica, mentre adesso sto concentrandomi sullo studio di materiali che consentano di utilizzare l’energia solare non per ottenere energia elettrica, ma energia chimica, in grado di causare una serie di reazioni.»
Possiamo fare qualche esempio?
«Certo: un esempio di questa reazione è la scissione dell’acqua, si parla in questo caso di sistemi fotocatalitici, in cui si separa l’acqua, ottenendo idrogeno ed ossigeno. È uno dei modi per ottenere l’idrogeno verde, uno dei combustibili del futuro: in questo caso si parla proprio di “combustibile solare”.
Un altro esempio è la riduzione dell’anidride carbonica, che attraverso la catalisi viene trasformata in altre sostanze utili, come acido formico o monossido di carbonio; queste sostanze rappresentano un’alternativa più sostenibile a quelle prodotte a partire da combustibili fossili. Questo procedimento è utile perché così si può sottrarre CO2 dall’atmosfera e riciclarla, ricavandone sostanze utili nell’industria chimica e in moltissimi ambiti.»
Come funzionano in questo contesto i nuovi materiali su cui lavorate?
«Al momento stiamo sintetizzando materiali attivi, ovvero funzionali, in grado di catturare la luce solare per poi utilizzarla come catalizzatore per provocare queste reazioni chimiche; cerchiamo di ottenere anche materiali ad alta porosità, ovvero che offrano una superficie molto ampia al contatto con l’elemento con cui devono reagire: allargando il campo di reazione si può infatti ottenere un’efficienza maggiore. Possiamo paragonare questi materiali microporosi a delle spugne. L’idea è quindi di combinare queste “spugne” con materiali semiconduttori, rendendoli quindi capaci di assorbire la luce del sole e generare delle cariche elettriche, come fanno i pannelli solari: ma mentre con i pannelli solari le cariche vengono estratte e fatte passare in un circuito esterno per generare elettricità, in questo caso le cariche restano sulla superficie del materiale e reagiscono, per esempio con l’acqua, o con un altro reagente, fornendo l’energia necessaria a ottenere la reazione chimica che desideriamo.»
Quali sono le applicazioni pratiche di queste tecniche?
«Nel caso della fotocatalisi dell’acqua, lo scopo è soprattutto ottenere idrogeno verde, ovvero un combustibile prodotto in maniera sostenibile. C’è poi lo scopo di ridurre sostanze inquinanti, in particolare i contaminanti organici che possono essere presenti nelle acque, per esempio sostanze coloranti: ci stiamo concentrando su grosse molecole organiche che possono essere ridotte attraverso queste reazioni elettrochimiche; rompiamo alcuni legami di queste molecole, in modo da spezzettarle e ridurle, trasformandole alla fine di tutto il processo in anidride carbonica. Un procedimento molto utile perché gli inquinanti organici presenti nell’acqua sono difficili da filtrare.»
Seguite criteri di sostenibilità anche nella sintesi dei nuovi materiali?
«Sì, per ottenere questi materiali seguiamo criteri di sostenibilità, cerchiamo di creare materiali performanti ma evitando il ricorso a sostanze tossiche, per esempio solventi tossici, che sono spesso utilizzati nella ricerca in questo campo: per esempio stiamo sviluppando e utilizzando la tecnica della sintesi meccanochimica, ovvero la creazione di materiali sintetici all’asciutto, senza necessità di ricorrere a solventi. Mescoliamo i reagenti in giare in cui vengono inserite delle sfere metalliche, per poi sottoporle a rotazione, con un moto planetario, ovvero intorno a se stesse e a un asse centrale: in questo modo l’energia chimica necessaria alla reazione deriva dall’energia meccanica, dovuta alla frizione tra le sfere e gli altri materiali. Il nostro lavoro è ottimizzare la sintesi, variando gli ingredienti di partenza, in modo da ottenere alla fine un materiale che abbia le caratteristiche che ci servono.»
Da quali materiali partite?
«Partiamo da sostanze dette precursori, che possono essere organiche o inorganiche, unite a dei modulatori: alla fine si ottiene un materiale cristallino, che ha una struttura ben definita. È un po’ come cucinare: bisogna scegliere gli ingredienti adatti, che alla fine ci facciano ottenere il piatto giusto. Per i materiali porosi, i cosiddetti materiali MOF (Metal-Organic Framework), per esempio, abbiamo trovato che la porosità ottimale si ottiene solo se aggiungiamo tra gli ingredienti un po’ di metanolo: non è quindi una sintesi completamente asciutta. Però è pur sempre una quantità di solvente estremamente limitata rispetto alla sintesi tradizionale di questi materiali, che prevede di solito una notevole quantità di solventi e di materiali tossici. Finché sono utilizzati in laboratorio per la ricerca, le quantità sono piccole: ma quando poi si arriva su scala industriale la presenza di materiali tossici nel processo produttivo può creare un problema ambientale importante. È per questo che nel nostro caso possiamo parlare di innovazione sostenibile. Tra l’altro alcuni di questi solventi, i DMF, molto utilizzati per la sintesi dei MOF, sono stati recentemente proibiti dall’Unione europea. Anche per questo è importante fare ricerca sulle alternative.»
Facciamo un ultimo esempio concreto di queste applicazioni
«Tra le altre cose cerchiamo di sviluppare semiconduttori che non contengano piombo, un problema che oggi esiste per i pannelli solari: cerchiamo da una parte di sostituirlo con semiconduttori che contengono solo materiali non tossici, dall’altro studiamo anche sistemi per riciclare i pannelli esistenti, rimuovendo e riutilizzando il piombo. Per portare a termine questo processo di riciclo, c’è il problema che ne resulta un’acqua di scarico che contiene piombo: stiamo studiando il modo di assorbire questo residuo attraverso i nostri materiali iperporosi.».