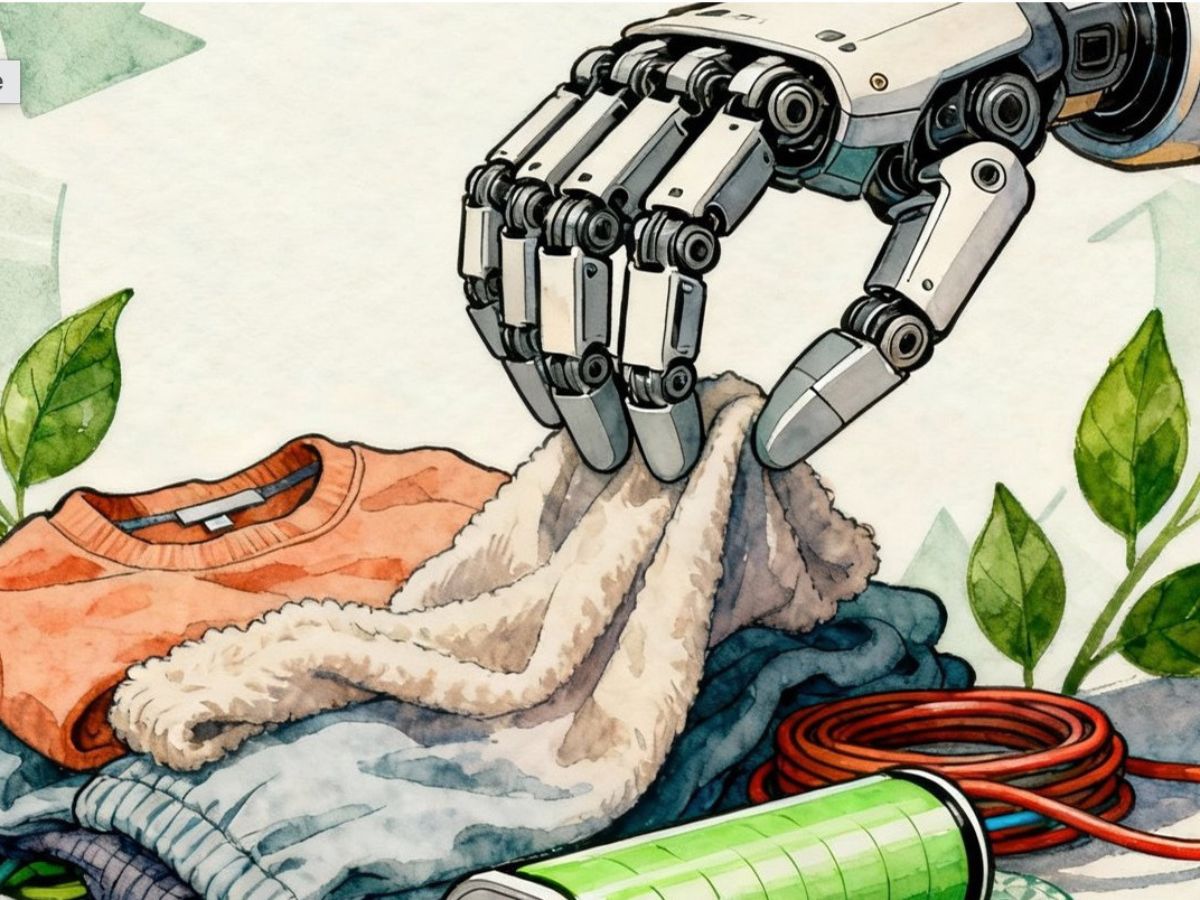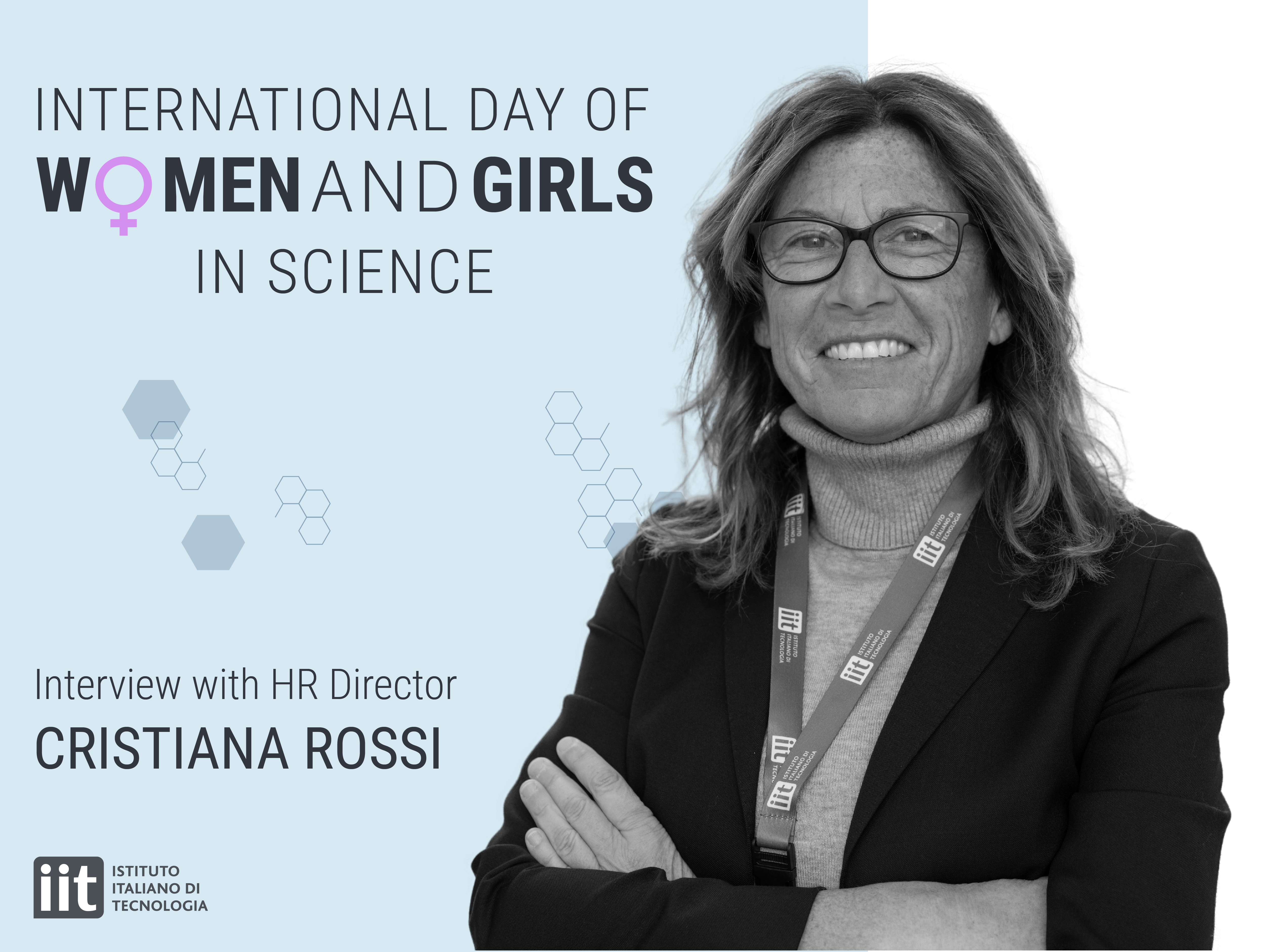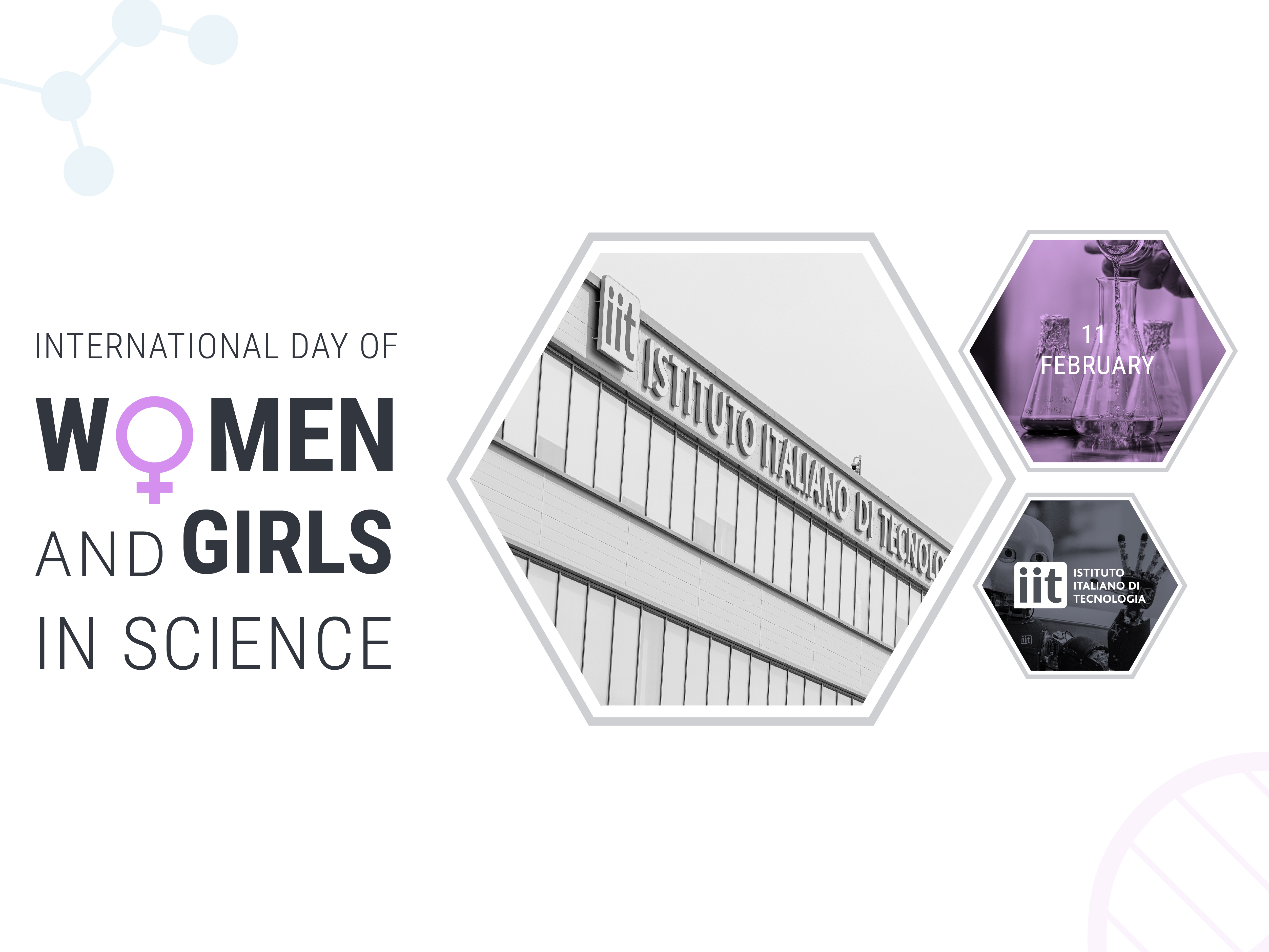Quando la ricerca scientifica incontra l’immaginazione senza confini della narrativa fantascientifica
È disponibile in edicola e in formato digitale Tecnologie del futuro, antologia pubblicata su Urania Speciale 2025 edita da Mondadori che raccoglie 13 racconti di fantascienza liberamente ispirati alle attività di ricerca condotte in altrettanti laboratori dell’Isitituto Italiano di Tecnologia.
L’antologia contiene i racconti di Marco Passarello, Paolo Aresi, Fabio Aloisio, Serena Barbacetto, Franci Conforti, Dario De Marco, Irene Drago, Alessandro Forlani, Lukha B. Kremo, Franco Ricciardiello, Salvatore Sanfilippo, Alessandro Vietti, Andrea Viscusi e le interviste ai ricercatori IIT: Arash Ajoudani, Mario Caironi, Angelica Chiodoni, Gianni Ciofani, Irene Farabella, Matteo Laffranchi, Guglielmo Lanzani, Annamaria Petrozza, Daniele Pucci, Claudio Semini, Velia Siciliano, Gian Gaetano Tartaglia, Arianna Traviglia.
Curatore del progetto editoriale è Marco Passarello, scrittore di fantascienza e giornalista RAI.
Passarello, che ruolo ha la fantascienza nell’editoria italiana oggi?
La fantascienza nell’editoria italiana ha goduto certamente di momenti migliori in passato. Oggi sono sempre meno le case editrici specializzate. Fortunatamente “Urania” resiste, e sono molto felice che questa pubblicazione, che raccoglie tra i migliori autori di sci-fi italiani, sia approdata sulle sue pagine.
Lei ha intervistato 13 Principal Investigator di IIT approposito delle attività di ricerca svolte nei loro laboratori, toccando tematiche che vanno dalla robotica alla genetica, dai nuovi materiali alle tecnologie per i beni culturali. Di seguito alle interviste, il lettore trova il racconto fantascientifico, liberamente ispirato, in cui immergersi. È rimasto colpito da qualche attività di ricerca particolarmente avveniristica?
In generale ho trovato tutte le ricerche di cui mi hanno parlato gli scienziati IIT molto interessanti e sorprendenti, in particolare il mondo della genetica mi ha affascinato perché ho compreso che siamo alla soglia di rivoluzioni epocali legate allo studio del nostro genoma. Devo dire che anche il robot umanoide volante di cui ho appreso dall’intervista fatta a Daniele Pucci era qualcosa che non immaginavo.
Scienza e fantascienza nascono come due mondi agli antipodi. Soggetta a revisioni tra pari “peer review” e regole dettate dalla comunità scientifica e comitati etici la prima, guidata dall’immaginazione e dalla creatività dei suoi autori la seconda. Secondo la sua esperienza, il lettore o la lettrice di fantascienza è un appassionato anche di scienza?
In generale sì, la maggior parte dei lettori di fantascienza sono anche appassionati di scienza. Nonostante in questi ultimi anni i confini tra i diversi generi letterari siano sempre più labili, io sono convinto che la caratteristica peculiare della fantascienza, che la distingue all’interno dell’enorme campo della letteratura fantastica, è che nelle trame di fantascienza si parte sempre da uno spunto plausibile e poi si approfondisce, tenendo la fantasia sempre ancorata al ragionamento.
Perché la fantascienza appare spesso interessata ad indagare scenari distopici?
Sicuramente per appassionare il lettore. Non dobbiamo dimenticare che la fantascienza è un genere di intrattenimento, quindi le tecnologie raccontate e le loro applicazioni devono riuscire ad interessare il lettore e per questo il più delle volte non vengono rappresentate le applicazioni di tutti i giorni ma vengono narrati gli scenari più variegati e spesso distopici. Tanta fascienza ad esempio, parla di macchine volanti che non abbiamo ancora nella vita di tutti i giorni e probabilmente non avremo mai. Io personalmente do anche un’altra interpretazione legata a contingenze storiche, forse oggi la fantascienza è particolarmente distopica perché il futuro non ci appare così brillante come appariva negli anni ’50 e ’60. Esiste, tuttavia, un movimento nella fantascienza che volutamente ha abbandondato il mondo distopico, cercando di sondare possibilità più propositive, proprio per dar vita a contenuti che potessero ispirare gli scienziati e questo è il caso del Progetto Hieroglyph dell’Arizona State University. In particolare, è proprio parlando con Bruce Sterling dell’antologia Hieroglyph che ormai undici anni fa era nata in me l’idea di lavorare ad un progetto letterario dove i racconti fossero ispirati da ricerche scientifiche svolte in un centro di ricerca italiano. Infine, esiste anche il Solarpunk che cerca di creare contenuti di fantascienza con una visione progressista del futuro, individuando una società alternativa a quella di oggi. In questo caso gli autori sono interessati a mostrare il percorso, anche travagliato, con cui le scoperte di oggi possono essere usate per costruire un futuro migliore.